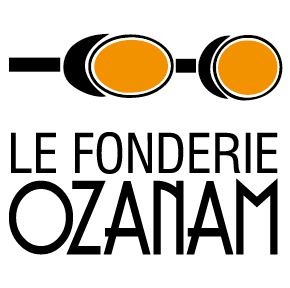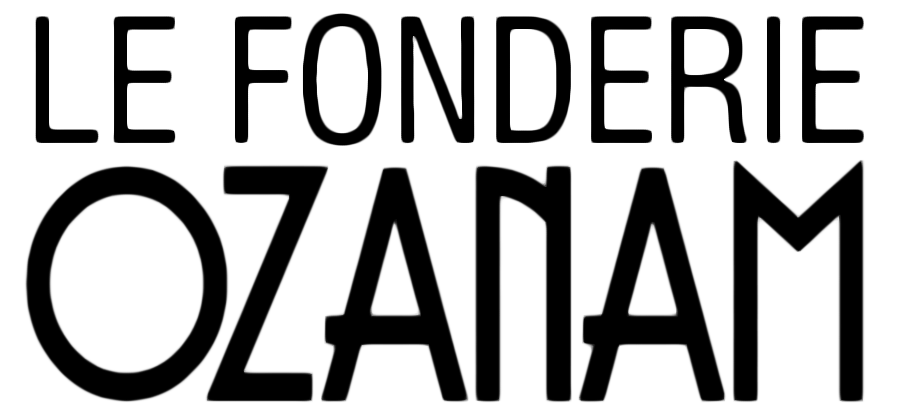Articolo scritto per il progetto cucine del Borgo da Alessandro Salvatico e Caterina Pira.
Hameed dimostra alcuni anni in meno dei trenta che effettivamente ha. Bei lineamenti, fisico slanciato da sportivo, capello portato lungo e di un nero lucente. La padronanza della lingua italiana, la cultura generale e quella scientifica, tutto contribuisce a far sì che l’ultima cosa che il suo interlocutore possa pensarne è che si tratti di un “richiedente asilo”, definizione che agli occhi di molti si attaglia a persone neglette, di scarsi mezzi e ancor meno possibilità.
Hameed è arrivato in Italia come studente del Politecnico, finché gli accadimenti nella zona in cui si trova il suo villaggio natale lo hanno costretto a chiedere all’Italia di accordargli la protezione internazionale, costringendolo anche a stare lontano per anni, lui così giovane, dalla sua terra e dalla sua famiglia. Ora le cose vanno meglio, e spera di poter presto tornare nel suo Pakistan.
È un ragazzo che ha vissuto molte vite, imparando anche tante cose, fra cui l’arte della cucina. Oggi ce ne darà un saggio cucinando la sua ricetta del charaj, piatto a base di carne d’agnello, pur se manca della strumentazione adeguata: andrebbe infatti cotto dentro un tegame particolare chiamato karahi, composto da due semisfere metalliche dove quella che sta sopra va appena a incastrarsi in quella inferiore, assumendo l’aspetto di un hang drum pronto a essere suonato, o di un disco volante alieno.
Il nostro cuoco sopperirà all’assenza dello strumento ideale con due padelle distinte: una sorta di wok per base e una di circonferenza leggermente più piccola per chiudere.
Il karahi comunque ce lo mostra in alcuni video presi dal web. Lì vediamo degli uomini cucinare, usando delle pinze con cui fanno ruotare le due semisfere che scaldano sul fuoco. I gesti sono tanto rapidi ed efficaci da farli sembrare quasi dei granchi umani.
Le immagini mostrano il Namak Mandi di Peshawar, il mercato del sale: chi ce le ha mostrate ci spiega che si tratta di un luogo celebre, di un mercato che si tiene ininterrottamente da quasi quattrocento anni, noto non solo per il cibo che ci si vende ma pure per quello che ci si cucina, sul posto: la gente arriva da lontano per visitarlo.
Nei pressi, ci racconta Hameed, c’è il distretto universitario con molti locali gestiti da afghani e detti Charski Tikka, dove la prima parola indicava in origine il fumatore di hashish (che come si sa, è un’eccellenza dell’Afghanistan, a modo suo).
“Ci andavo spesso, negli anni in cui studiavo a Peshawar”, racconta Hameed, “e pure lì, nei ristoranti, studiavo”. E cosa? I piatti: cercava di carpire ogni nozione su come i migliori cuochi preparassero i più buoni.
É lì che ha appreso come migliorare il suo charaj. Ma c’era un segreto che proprio non riusciva a rubare; un ingrediente che mancava sempre, quando a casa cercava di replicare la ricetta.
“Ho impiegato tre anni di continue richieste, per farmi dire cosa fosse”, ricorda Hameed. Era l’acqua di riso.
Fatta fermentare con aglio e zenzero, non si trova nei negozi ed era un vero segreto. Oggi l’acqua di riso, nella sua versione basilare e semi-industriale, è stata scoperta anche dalla cosmetica occidentale per le sue numerose proprietà benefiche.
In cucina, invece, “Dà alla carne un gusto diverso, la fa diventare morbida in poco tempo, si assorbe del tutto in soli 45 minuti. Viene usata anche per la marinatura: talvolta la carne viene lasciata una giornata intera in frigo per farla diventare ancora più tenera e saporita”, spiega.

Ma anche dopo aver scoperto questo segreto, c’è ancora del rammarico: “Non mi hanno mai rivelato come funzionasse esattamente il processo di cottura”. Si dispiace quindi di non poter aggiungere quel sapore speciale e ci consiglia col cuore di andare a provarlo in Pakistan!
Intanto Hameed mette e scaldare aglio e cipolla, sminuzza zenzero e coriandolo con l’aiuto di Naseer, suo amico e conterraneo, ragazzo che vive nell’ostello che è parte del complesso BeeOzanam.
Hameed è da poco diventato il custode della struttura, all’interno del progetto di accoglienza dello European Research Institute in cui da tempo lavora come mediatore interculturale, anche se, a detta sua, “non si tratta di un lavoro, ma di una parte della mia vita”.
I due amici provengono dall’area settentrionale del paese, parlano entrambi la lingua pashto e sono avvezzi allo stesso tipo di cucina che, come tutta la cultura della zona, è fortemente frammista di influenze afghane.
Il Pakistan infatti è un paese “realmente” federale, non si tratta solo di una questione amministrativa, ma culturale: etnica, linguistica e pure gastronomica. Una varietà che riflette la ricchezza naturalistica di questa terra, dal sud lussureggiante dove i coccodrilli nuotano nelle foci dell’Indo, passando per i deserti dell’est e risalendo sino alle montagne del nord dove vivono i leopardi delle nevi.
Tante differenze, che sanno essere superate quando il popolo pakistano deve dimostrarsi unito. Come all’epoca della lotta per l’indipendenza dall’India. O come quando viene inscenato il vero miracolo unificatore delle genti di quel paese: il cricket. Se il calcio è il moderno oppio del popolo per gli italiani, il cricket è il rito semi sacro del Pakistan. Pressoché ignorato dalle nostre parti, è in realtà uno degli sport più popolari del mondo.

Un recente “derby” della squadra nazionale contro l’omologa dell’India ha registrato oltre un miliardo di telespettatori: un essere umano ogni sette, sul pianeta, stava guardando quella partita. Mentre inizia la prima cottura dell’agnello, Hameed ci rivela il ruolo che riveste per lui il cricket e soprattutto il ruolo che lui riveste per il cricket.
Ed è una storia pazzesca, che intreccia in maniera inaspettata le storie del nostro e del suo sport nazionale, della nostra e della sua città, in un nodo incarnato proprio da lui (e dai suoi compagni di avventura). Prima è necessario fare un passo indietro, nella Storia con la “s” maiuscola.
Nella seconda metà del XIX secolo arriva in Italia il calcio, o meglio il foot-ball, e ci arriva da quella porta d’ingresso che è la città di Torino. Giunge dall’Inghilterra, dove gli sportsmen si danno abitualmente al cricket e qualcuno, da qualche tempo, anche questo a nuovo gioco; le società che all’uopo vengono fondate dai nobiluomini del tempo sono infatti volte alla pratica delle due discipline: “Torino Football & Cricket Club”, “Genoa Cricket & Football Club”, e così via, messe in piedi da gruppi di britannici con l’inserimento di qualche sportivo autoctono.
Con il tempo, gli inglesi se ne vanno. Restano gli italiani che, senza una propria tradizione, presto abbandonano le sezioni di cricket dei vari club al proprio destino.
La recente formazione di una comunità pakistana sul nostro territorio ha significato anche l’ingresso di persone che volevano giocare al loro gioco; fra questi, Hameed e i suoi sodali che, ricchi di spirito d’iniziativa, non si sono limitati a mettere insieme una squadretta, né a fondarne una nuova.
Hanno compiuto le operazioni giuridiche necessarie a rilevare il titolo sportivo del primo, originario club di Torino, quello da cui ha avuto origine anche l’attuale Torino del calcio, sezione rimasta lì vacante e oggi in mano a questo gruppo di ragazzi volenterosi che può fregiarsi di una fondazione datata 1887 e che si sente portatore della tradizione torinese del cricket.
Non solo: essendo intraprendenti, sono riusciti a farsi patrocinare dal Zalmi, il club professionistico di Peshawar vincitore della Super League nel 2017, potendone ora usare il brand e il materiale.
A quest’opera imponente manca “solo” un minimo d’interesse da parte delle amministrazioni pubbliche, che ancora non dotano i club di un campo regolamentare.
Hameed e Naseer ci raccontano tutto questo mentre procedono con la cottura dell’agnello, la carne più comune nella zona da cui provengono. “Ci si fanno molti piatti diversi, alcuni davvero impegnativi come il rosh, o come il kuddi kebab, dove l’animale viene farcito e cotto per otto, dieci ore”.
Il capocuoco di giornata spiega di aver scelto il charaj perchè ha un gusto meno ricco di sapori piccanti, o di cipolla, e gli sembrava più prossimo alle preferenze occidentali. Ma c’è anche un’altra ragione:
“Il Charaj è uno dei primi piatti che ho imparato a cucinare, insieme a mia mamma.”
“Lei era sola, e io la aiutavo, specialmente in periodo di Ramadan, dove mi ha insegnato le basi. Lo preparavo anche in occasione di alcune feste con gli amici, avevo quattordici anni. Certo, per arrivare a certi risultati, per raggiungere i livelli che provavo e studiavo nei ristoranti, ci è voluto del tempo”. Eppure da quelle parti la capacità culinaria è prerogativa femminile; com’è nato dunque questo interesse nel ragazzo che abbiamo di fronte a noi?
Ce lo spiega lui, ed è una spiegazione che fa nascere un sorriso dolce sui nostri volti mentre ascoltiamo. “Da ragazzino frequentavo la scuola religiosa, in particolare una madrasah”. Il mondo islamico non è il monolite che alcuni immaginano: è percorso da interpretazioni, atteggiamenti e persino scuole differenti, come le scuole coraniche, o quelle annesse alle moschee, o le maktab, o appunto le madrasah, centri di istruzione superiore.
“Il mio maestro mi ha insegnato che se qualcuno aiuta sua mamma, nel Ramadan in particolare, andrà in paradiso”
“Il paradiso è sotto i piedi di mamma”. E io non me lo sono mai dimenticato”. Così è nato il suo avvicinamento alla cucina.

Una vera e propria passione, non da tutti compresa e accettata: “Purtroppo nel mio villaggio di montagna, se un uomo si mette ai fornelli non viene rispettato; dicono che sei come una donna. Ma io non ci facevo caso, volevo andare in paradiso. Perciò aiutavo mia mamma!”.
A tutti i protagonisti del nostro viaggio culinario abbiamo sempre chiesto quale molla che li avesse spinti a diventare bravi cuochi, professionali o meno. Questa è la prima volta che la motivazione risiede addirittura nell’altro mondo.
In ogni caso, i riflessi di questa abilità risultano comunque piuttosto pratici e concreti: “Saper cucinare ti aiuta nella vita adulta, quando vai via di casa”, argomenta Hameed, proseguendo poi con orgoglio: “Da qualche anno cucino per la moschea in occasione delle feste, in tanti vengono a mangiare gratuitamente.
Nelle ultime occasioni ho preparato piatti per duecento, trecento persone. Una volta anche per quattrocentocinquanta! Penso a chi, in Pakistan, diceva che imparando a cucinare io stessi facendo qualcosa di sbagliato e ora sono nella posizione di gestire cinquecento persone. Non da solo, naturalmente, ma sapendo cosa fare e come farlo fare”.
L’agnello sta assumendo profumi nuovi. Il charaj è un piatto molto tecnico, che richiede alla carne di passare attraverso tre diverse cotture: nella prima fase si cuoce grazie al vapore, poi subisce una veloce frittura e infine riposerà in umido con i pomodori che la circondano e si disfano, diventando una salsa impreziosita dalle spezie.
“Quando sono arrivato in Italia”, riprende il cuoco, “vivevo con dieci amici e nessuno di loro sapeva cucinare. Nessuno lo aveva mai imparato. Per un anno li ho aiutati, insegnavo a cosa fare attenzione, cosa mettere e cosa no, ed è stato bello”. Quando parla di “attenzione”, Hameed si riferisce soprattutto alle spezie: “L’effetto che fanno sullo stomaco, qui, è diverso da quello che fanno nella mia terra”, garantisce. “Ci sono diverse spezie che possono essere consumate a piacimento in Pakistan, mentre qui causano dei disturbi all’apparato digerente”.

Le osservazioni di Hameed non sono espressione di quel campanilismo che spinge a identificare il “meglio” con il “mio”. Tant’è vero che ha imparato ad apprezzare la cucina locale, al punto da includerla nei suoi piani per il futuro.
“Ora vorrei tornare per un po’ nel mio paese, manco da troppo tempo. Poi, vorrei rientrare e aprire un ristorante. Ma ristorante non è il termine adatto: vorrei che fosse più una scuola”.
Il suo progetto ci affascina, non foss’altro per la prossimità con quel che stiamo facendo noi stessi.
“Una scuola per imparare a cambiare i propri gusti. Per scoprire cose nuove e saperle apprezzare.”
“Perché chi mangia qui spesso non sa comprendere il gusto di altri paesi. Per abituarsi ad altri gusti c’è bisogno di creare tante proposte diverse, di cambiare, di spiegare…”, sembra stia parlando anche per noi. “Mi piacerebbe prendere alcuni elementi del cibo italiano, alcuni di quello pakistano, per creare un gusto…diverso”.
Intanto è giunto il momento di provare il gusto diverso del charaj, che nessuno di noi conosce ancora. Stiamo per conoscerlo e non lo dimenticheremo più. La consistenza della carne è quasi di difficile comprensione, frutto delle diverse cotture cui è stata sottoposta, e il suo sapore è delizioso.
Compatta ma succosa, la immaginavamo più forte di come si presenta: al suo aroma impattante corrisponde un sapore delicato, che non traumatizza le papille. L’aspettativa e la realtà rispecchiano in fondo quella variegata realtà pakistana di cui si diceva: quella di Hameed è nei fatti una cucina centroasiatica, più lontana di quanto possano dire le mappe da quella, pur sempre pakistana, che si può trovare nelle regioni meridionali più attigue all’India.
Mentre con le forchette ci infiliamo tra le fauci succulenti bocconi di carne, ciascuno dal proprio piatto, osserviamo Naseer e Hameed giungere allo stesso risultato partendo però da un unico vassoio e servendosi con le mani.
Hameed comprende i nostri sguardi e ci anticipa: “Vi racconto una storia”, fa. E ci narra di una donna italiana che ha conosciuto, che era in Afghanistan al seguito dell’esercito statunitense e dei loro alleati. Una donna che aiutava le persone.
Un giorno venne invitata a casa dalla famiglia di qualcuno cui aveva prestato soccorso, le vennero porti forchetta e cucchiaio mentre gli altri mangiavano con le dita; proprio come qui, ora. Lei chiese il perché della loro abitudine e le venne risposto che così il gusto era maggiore, più buono.
Il nostro cuoco argomenta: “Ci sono ricerche scientifiche che confermano che sulla nostra pelle si trovano delle cellule ricettive che contribuiscono ad aumentare la percezione del sapore”. Poi aggiunge che per lui si tratta anche di una questione di libertà, la libertà di mangiare come si vuole. “Come i bambini,” dice, “nessuno è libero quanto loro: mangiano divertendosi, godendo il cibo, sporcandosi. Il gusto è lì, non è nel lasciare il piatto pulito”.
Il suo racconto prosegue: “Quell’infermiera poi tornò in Italia e venne invitata a casa dai miei amici afghani. Quando iniziò a mangiare, tutti spalancarono gli occhi: stava prendendo il cibo con le mani!
Lei affermò che stava facendo come i bambini, i quali non pensano a cosa diranno gli altri, ma a fare quel che gli piace di più.
Ed è proprio così: in Pakistan noi mangiamo insieme, ma comunque ognuno a modo suo. Noi diciamo che il piatto è come una nazione, ci sono ruoli e confini e nessuno deve oltrepassare quelli altrui senza consenso.
Si mangia insieme, ma ciascuno ha la propria parte; così nasce un senso di condivisione ma anche di rispetto. Nel tuo cuore, stai condividendo il tuo cibo con un’altra persona”. Quanta poesia e quanta meravigliosa e differente umanità si può trovare, in un piatto solo. O in più piatti, come si preferisce.