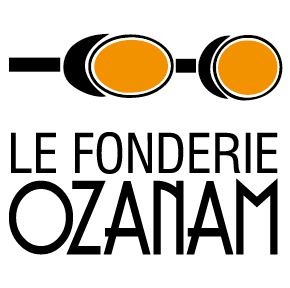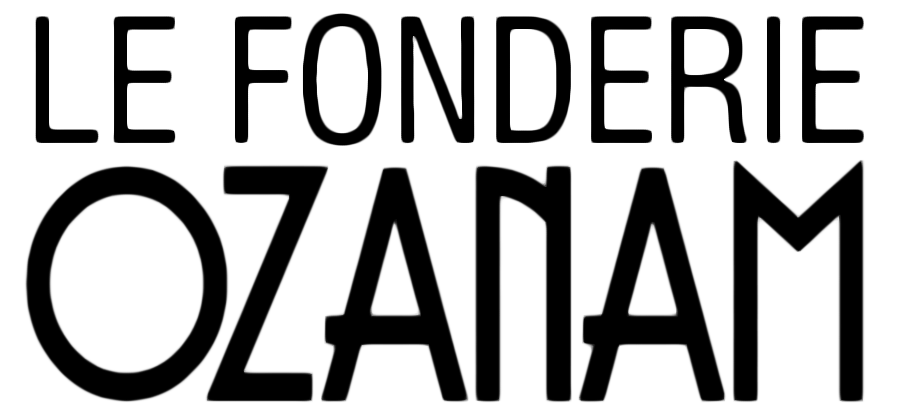Articolo scritto per il progetto cucine del Borgo da Alessandro Salvatico e Caterina Pira.
Le città di oggi hanno spesso confini slabbrati di caseggiati alveare o di graziose bifamiliari con giardino, realtà apparentemente opposte ma accomunate dalla totale assenza di una storia alle spalle della propria formazione e dalla loro essenza di vasto dormitorio.
Contrapposti a questi luoghi un po’ spersonalizzati, esistono i quartieri. I quartieri, nati da una cellula primigenia che tutt’ora – a distanza di decenni oppure di secoli – ne costituisce il cuore pulsante; quelli che dal cuore vedono dipanarsi le arterie principali, e via via fino ai capillari delle stradine private.
Borgo Vittoria è un quartiere di Torino, un organismo complesso e vitale, con organi importanti come il rinnovato BeeOzanam che si affaccia tra via Foligno, via Stradella e largo Giachino. E se il cuore che batte è la piazza del mercato omonima, la piazza della Vittoria, l’aorta è sicuramente via Chiesa della Salute.

Su “via Chiesa” arriviamo infine laddove, sino a pochi mesi fa, pulsava uno dei molti gangli che la mantengono florida: un negozio di generi alimentari pugliesi, da cui uscivano come da un’inesauribile miniera delizie dolci e salate a due passi dalla chiesa che dà il nome alla strada. Un negozio gestito per ben diciassette anni dalla signora Maria.
Maria è un vulcano di pugliesità. Arriva nelle cucine del ristorante dove la aspettiamo e inizia a tirare fuori dalle sporte i vari ingredienti, pochi minuti dopo già si muove tra i fornelli da padrona di casa, come se fosse stata lei ad averci invitato, e non il contrario.
La accompagnano la giovane figlia Patrizia e il genero Savino, una famiglia unita ma non chiusa, che sprizza energia e giocosità. Madre e figlia oggi cucineranno, si racconteranno e siccome sono in due hanno pensato di proporre due piatti, uno salato e uno dolce.
Quest’ultimo sarà una torta di ricotta, il primo invece è il noto binomio di fave e cicoria, tanto conosciuto da venir pronunciato come una cosa unica, “faveccicòria”. Ma il lavoro della ex-commerciante in pensione inizia proprio dalla torta.
“Senti il profumo del limone?”, ci chiede col suo accento pugliese mentre ne grattugia rapida la scorza dentro la ciotola. “Chiedi di là se hanno un pezzo di cioccolato, se ce l’hanno, ce lo mettiamo!”.
Oggi iniziamo prima del solito a leccarci i baffi preventivamente, come fanno i gatti quando sentono i profumi, prima ancora che i sapori, delle leccornie che li attendono. Poi Maria sorride, mentre continua ad aggiungere ingredienti nella boule: “Io non facevo mica delle scodelle così”, dice fra il divertito e l’intenerito, “ne facevo di enormi: quindici o sedici torte alla volta!”.

Nel suo negozio l’organizzazione era paramilitare: nulla da invidiare ai grandi laboratori di pasticceria o alle cucine della ristorazione professionale. “E non ho mai pesato niente, sempre tutto a occhio. Oh, venivano sempre bene! I clienti non si sono mai lamentati!”. Anzi, ora che ha chiuso, il problema è…toglierseli di dosso: la cercano, alcuni le telefonano a casa, pregandola di preparare ancora qualcosa per loro. “Almeno la Pizza Sette Sfoglie!” la supplicano.
I nostri sguardi tradiscono l’ignoranza, quelli dei tre ospiti lo stupore che ne consegue. È il genero a esclamare: “Aspettate…non sapete cos’è la Sette Sfoglie? Dovreste rimediare al più presto, è una bomba nucleare…” “Sì,… di calorie!”, aggiunge Maria ridendo.
Arrivata a Torino nel 1966, ha prestato servizio in fabbrica, poi per undici anni ha lavorato in un bar, prima che nel negozio: “Cinquant’anni di lavoro!” ricorda lei stessa. Ma nelle mani, un talento autentico, non solo da commerciante ma da vera pasticcera.
L’ormai celebre Sette Sfoglie, per esempio, richiede un lavoro enorme: “Tanto per cominciare devo tostare le mandorle e poi tritarle, poi ci vuole la mostarda d’uva e io mica la compro, la faccio. Prendo l’uva e tolgo tutti i semini a uno a uno, chicchetto a chicchetto, poi la faccio cucinare per sette, otto ore, ci vuole una montagna d’uva solo per farne quattro vasetti…”, e punta nell’orgoglio interviene la figlia: “…E poi arrivano i clienti e ti dicono: “Ma è un po’ cara!”.
Non si rendono conto della fatica che c’è dietro! E alla fine ti arrendi, lasci il posto a quelli che usano sistemi diversi, perché se lavori in un certo modo tanto non viene compreso”, conclude con un pizzico di amaro.
Maria intanto aggiunge le uova alla ricotta e continua a mescolare con la cucchiarella, non frullerà nulla perchè preferisce una consistenza finale più rustica. Ha appaltato alla figlia la preparazione dell’altro piatto della giornata.
Può sorprendere che a fronte di tanta abilità culinaria la scelta sia caduta su qualcosa di così semplice come fave e cicoria, ma non dovrebbe: se si parla delle sue origini, niente le esprime e sintetizza meglio di questo povero, squisito piatto contadino.
“Una volta le donne andavano a lavorare nei campi, e poi tornando a casa raccoglievano nei grembiuli tutte le erbe che trovavano, le portavano sul tavolo per pulirle e ne facevamo minestra per i figli”
Fra queste, le cicorie. Le fave invece beneficiano del privilegio riservato a tutti i legumi: coltivate dalle varie famiglie, si conservano secche alla perfezione anche per tutta la durata dell’inverno.
Ciò che per Patrizia è racconto, per Maria è memoria: “Proprio d’inverno cresce la cicoria, che mia mamma portava a casa insieme al finocchietto e a tante altre erbe”, e prende a elencarne alcune con i nomi che sua madre usava, i nomi dialettali che noi a volte non riusciamo a tradurre.
Le più tenere si mangiavano subito, quelle più resistenti finivano in qualche zuppa: non si buttava mai niente, i risultati saziavano ed erano buoni. “Ci preparava erbe con le fave, o con i fagioli, con o senza pasta… La carne era una cosa di poche volte. Erano questi i piatti che sfamavano la famiglia, che doveva mangiare ogni giorno, noi eravamo dieci figli!”.
Il segno della povertà non si cancella mai. Ma col tempo, da tragedia può diventare farsa, da preoccupazione quotidiana può essere sfumato con un sorriso.
Così, quando è il momento di tagliare la cipolla, Maria la estrae da una borsa e la figlia sottolinea: “Vedete? Ci siamo portati la cipolla da casa; non sai mai, può darsi che nelle cucine di un ristorante non abbiano una cipolla”, ironizza. Poi aggiunge ridendo:
“Non potete capire, quando mia mamma va a mangiare al ristorante, si porta da casa il peperoncino avvolto in un tovagliolo!”.
La ragazza cerca l’olio da versare in padella, quell’olio che da molti viene associato alla Puglia in un ideale binomio inscindibile; ma ancora una volta, quel che crediamo di sapere – anche su pezzi della nostra Italia, non solo su luoghi lontani – è più di quel che a conti fatti conosciamo davvero. “No, macchè olio? Olio non ce n’era!”, esclama Maria riferendosi alla sua giovinezza “giù”.
Con la nostra cuoca, ogni elemento può essere lo spunto per una riflessione, a volte malinconico, più spesso divertito, sempre interessante. “Una volta da noi si usava tanto lo strutto”, ci spiega, prima di illustrarci un mondo che sembra lontanissimo dal nostro.
Eppure parliamo sempre dello stesso paese in cui anche noi siamo nati e cresciuti e della distanza temporale di una sola generazione. È il potere delle migrazioni: chi emigra, vive due vite anziché una sola. Raddoppiano anche le esperienze, le conoscenze, le capacità; acquisendone di nuove ma senza abbandonare per strada il proprio bagaglio.
“Due o tre volte l’anno, ammazzavamo un maiale” riprende Maria. E si sa che del suino non si butta via niente; con il maiale arrivava tutto il necessario.
“Ne ricavavamo lo strutto, poi lavavamo bene la vescica della bestia e lo mettevamo lì dentro; si formava una palla con cui potevi cucinare per tutto l’anno! Il frigorifero o il congelatore non c’erano, quindi lo lasciavamo all’interno di alcune grotte e perchè si conservasse meglio lo mettevamo dentro la sugna”.
Strutto, sugna, sono parole quasi tabù nella nostra quotidianità salutistica. La narratrice mugugna: “Con lo strutto i dolci vengono meglio, più friabili, più buoni. Se è di qualità nemmeno si sente il grasso! Ma adesso sono tutti vegani, se lo usi non ti comprano più i dolci! Che poi lo strutto mica fa male: sono le altre porcherie che ci mettono, tipo la margarina, le cose da evitare!”.
Intanto osserva la figlia, e collega il racconto al momento presente: “Ecco, avessimo dovuto fare fave e cicoria ai miei tempi giù al paese, avremmo aperto la vescica, preso un cucchiaino di strutto e fatto soffriggere quello, e… E mettine di più!”.
Qui si accende un divertente dibattito madre-figlia sull’uso dell’olio d’oliva, un dibattito molto italiano: la prima rimprovera la seconda di averne versato troppo poco. Alla fine passa dalle parole ai fatti, prendendo la bottiglia e operando una generosa aggiunta, mentre la seconda scoppia a ridere assicurandoci che si tratti di una scena consueta.
Maria ribatte: “E che devi fare? Se non ci metti l’olio, di cosa sa fave e cicoria? Allora fai prima a prendere la cicoria, fartela bollita e mangiartela così!”.
Per un attimo, mormora quasi fra sé e sé: “Che poi è buona anche bollita, la cicoria…”, ma è solo un momento, perché subito riprende vigore (e volume): “…Ma se invece devi fare questo, lo fai come si deve; se vuoi fare le cose dietetiche, mangiatele a casa!”. E mentre noi scoppiamo a ridere, la più giovane cede il passo anche sulla cipolla: “Guarda, tagliala tu, che poi mi sgridi per come l’ho fatto!”.

Savino sorride guardando il quadretto famigliare, mentre le fave continuano a cuocere. Non è comune incontrare una famiglia che emani un’impressione di unità così immediata e un’intesa tanto naturale fra i suoi membri.
“Racconta della seccia gabbata, dai!”, suggerisce ora la figlia alla madre, occupandosi ancora della premessa: “Si tratta di un altro piatto povero contadino; “seccia gabbata” significa “la presa in giro della seppia”, perchè infatti…non c’è! C’è solo il ripieno. Racconta, mamma!”.
Maria ride e accoglie l’invito. Da vera intrattenitrice, attacca ripetendo il nome del piatto, come fosse il titolo di una fiaba che si appresta a raccontarci: “La seccia gabbata. Una volta non c’erano i soldi per comprare la seppia; cioè, qualcuno magari li aveva, ma noi, no.
Allora facevi così: preparavi delle polpette di pane, dentro mettevi un po’ di formaggio, di peperoncino, naturalmente l’uovo, quindi aglio e prezzemolo. Quando le mettevi a cucinare con un poco d’olio, si sentiva un profumo tale che chi passava chiedeva: “Ma cos’hai cucinato, la seppia?”, e tu rispondevi: “Oggi no, la seccia gabbata!”…”.
Intanto le fave sono diventate una crema, che viene versata nella pentola della cipolla, pronta ad accogliere la cicoria cotta che vi si tufferà dentro. Pochi minuti ed è tempo di assaggiare. Avete presente le degustazioni nei film americani a basso budget, con l’attore-assaggiatore che chiude gli occhi per far comprendere allo spettatore medio la goduria provata?
L’immagine descrive la nostra reazione al provare questa favolosa crema pugliese, mentre Maria fissa ammiccante i nostri volti che si muovono al rallentatore, domandandoci retoricamente: “Allora, è un piatto da passare…?”. Tanta bontà è sorprendente e inattesa, e non perché le nostre aspettative fossero basse.
Il cervello manda un unico messaggio, che ripete a ciclo continuo: vorrebbe che non finisse mai, che ce ne fosse ancora, che non finisse mai, che ce ne fosse ancora…
“Purtroppo io a casa non cucino”, dice la signora, ma figlia e genero la guardano piegando il capo e sollevando le sopracciglia. Lei se ne accorge e protesta: “Ma è vero! Mio marito è diabetico, mia figlia sempre a dieta, io non voglio buttare nulla quindi finisce che mi gonfio, allora non cucino. Dicono che faccio troppa roba”. Dicono.
“Ma certo, non cucina mica”, ironizza Patrizia, che racconta di quando, qualche mese fa, soleva invitare la mamma a superare la fase successiva alla chiusura dell’attività lavorativa con qualche passeggiata, o qualche attività che le impegnasse il tempo ma che non fosse quel che era stato il suo mestiere di una vita.
“E arrivata a casa sua, cosa trovo? Pane sfornato, pizza, torte!”. Maria si dichiara colpevole e aggiunge:
“Sì, quel giorno ho cucinato la torta di ricotta, le crostate, la pizza, il pane, le pizze fritte… Ma insomma! Se non faccio niente non va bene, se faccio non va bene!” si lamenta, mentre la figlia cerca di spandere saggezza: “Ma una via di mezzo, mamma!”. Noi e Savino assistiamo, sempre divertiti.

A proposito di torta di ricotta: è il momento di infornare. Anche questa crostata è un ricordo di Puglia, di quando la famiglia d’origine dei nostri protagonisti aveva la vacca e la pecora.
Dal latte ricavavano diverse ricotte con cui fare dolci come quello che assaggeremo fra mezz’oretta.
“Ho imparato a cucinare con gli occhi”
Dice la cuoca ricordando delle tante giornate passate a osservare la madre, insieme alla sorelle, quella piccola quasi coetanea e quella grande che si occupava della casa, ma che poi si sposò e se ne andò su, in Piemonte.
Con la signora Maria funziona così: ogni parola si può portare dietro un aneddoto per la nostra gioia. “Mia madre ripeteva sempre a noi due piccole: “Vostra sorella alla vostra età faceva la pasta!”, rimproverandoci. Allora un giorno decidemmo di dimostrare di non essere da meno: se lo faceva lei, potevamo farlo anche noi!”.
Ci narra di come lei e la sorella presero a fare la pasta, andando per a tentativi: prima risultava troppo molle quindi aggiungevano altra farina, poi troppo dura quindi versavano più acqua, poi di nuovo altra farina per riequilibrare, finché venne fuori una quantità di impasto talmente spropositata da spingerle a mettere a lavoro non solo i fratelli, ma anche tutti i bambini del circondario: tutti a fare i cavatelli.
“Ma non c’era più spazio per metterli: avevamo coperto tavoli, mobili, letti ed era ancora avanzato dell’impasto! Lo abbiamo nascosto nel cassetto del comò, dove c’era la biancheria.
Quando nostra madre rientrò, disse solo: “Madonna!” mettendosi le mani nei capelli”, ma non si arrabbiò. Anche se chili e chili di pasta erano inutilizzabili (molti bambini li avevano fatti direttamente sul pavimento), alla peggio avevamo i maiali cui darli da mangiare.
Ma non finisce qui: nei giorni successivi, andava crescendo in casa un tanfo acido di cui non si scopriva l’origine. Finché la capofamiglia riuscì a svelare il mistero, aprendo il cassetto e trovandoci dentro quell’impasto ormai rancido…! Non so, è una storia che proprio mi è rimasta…”.
Proviamo piacere a scoprire che le capacità apprese da quella bambina non sono andate perdute: le ha acquisite bene la figlia, come vediamo con i nostri occhi e proviamo con le nostre gole, e sono state trasmesse anche alle deliziose nipotine, che spesso passavano del tempo in negozio con loro, in via Chiesa.
Maria racconta di come la prima delle figlie di Savino e Patrizia giocasse a fare i cavatelli a dieci mesi, e a quattro o cinque anni sapesse fare le orecchiette: “Quanto era brava!”, dice con l’amore di nonna che le brilla negli occhi.
E non può che essere vero, dato che parliamo di un’insegnante severa, come la stessa Patrizia ci fa presente: “Mia mamma ha seguito un po’ di persone che venivano da lei per perfezionarsi nel fare – per esempio – le orecchiette. Se non facevano le cose per bene lei li sgridava! Quelli dicevano: “Ma io sono abituato così”, e lei ribatteva: “E allora stattene a casa! Sei venuto per imparare!”.

La torta intanto è cotta. La fetta (la prima delle fette…) che ne mangiamo è una dolce delizia avvolgente, è morbida ma si sentono i singoli elementi che la compongono, è ben lontana da certi mix fluidi partoriti dalle macchine.
Chiediamo se anche questa crostata fosse una tradizione pasquale, un po’ come accade con la pastiera nel napoletano. Come sempre in questo bel pomeriggio insieme, bastano poche parole per dare la stura all’infinito serbatoio di memorie di Maria.
Il dolce di Pasqua, dalle sue parti, è la squarcella, quella con l’uovo sodo all’interno. “Sembra un biscotto ma non lo è, se ne preparavano alcune diversi giorni prima della festa, si rassettava a fondo la casa, al centro si poneva una tovaglietta ricamata con le squarcelle sopra. Ma poi non si potevano toccare…”.
E perchè? “Bisognava aspettare che passasse il prete a benedirle! Passavamo giorni a chiedere: “Mamma, possiamo?”, quando alla fine arrivava il prete, ah!, le uove bollite con la squarcella… A colazione, che bontà. Con un po’ di vino…”.
Vino? Ma non stavamo parlando dei ricordi di una bambina? Figlia e genero guardano la capofamiglia con un sorriso e la stuzzicano: “Dai, di un po’ come facevate colazione!”.
Maria coglie la palla al balzo: “La mattina noi bambini prendevamo uovo fritto e peperoncino. Poi, sai com’è: l’acqua corrente in casa mica c’era. Però il vino sì: avevamo una botticella, si andava lì con la caraffa di terracotta e si riempiva, ci bevevamo un bel bicchiere di vino e poi via, andavamo a scuola, sempre con gli scocchetti belli rossi in faccia… E non per il freddo e la neve che c’erano fuori!”.
Ridiamo increduli, mentre i narratori ridono a loro volta tanto per il racconto quanto per la nostra incredulità, mentre la signora continua: “Oppure tante volte facevamo colazione con la cotenna di maiale con la pancetta, si faceva soffriggere quello con un po’ di salsa fatta in casa e un po’ di peperoncino, si bagnava il pane lì dentro, si mangiava con un bicchieruccio di vino e si andava a scuola!”.
Ormai siamo lì lì per fare un applauso alla protagonista. “Io il vino l’ho sempre bevuto da quando son nata! E che cervello c’ho? Non vi sembro mica stupida, giusto? Ho una memoria che ricordo sempre tutto, a sessantasette anni!”.