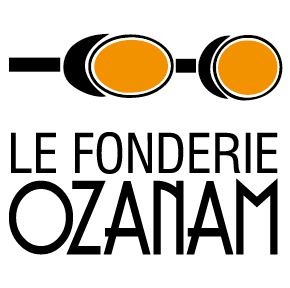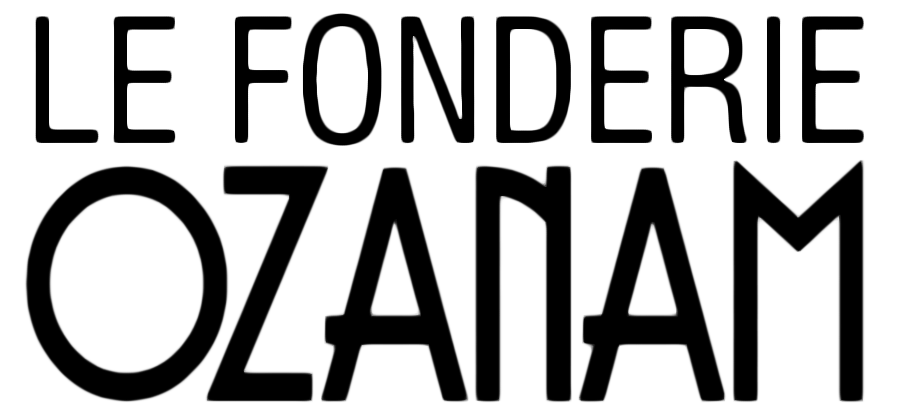Articolo scritto per il progetto cucine del Borgo da Alessandro Salvatico e Caterina Pira.
Gli occhialini sul naso sono quelli di un professore. La camicia a quadri, le dispense rilegate con le spirali e i vari libri sparsi per casa, lo confermano. La voce poi non lascia spazio a dubbi: la pronuncia distinta delle parole, la linearità delle frasi di chi è abituato a spiegare concetti. Di chi ama farlo.
Jean-Baptiste Tolo infatti insegna il francese agli studenti del “Majorana” di Moncalieri, mentre con quelli del “Bobbio” di Carignano lavora sul progetto EsaBac, che punta alla mobilità transnazionale italo-francese per i giovani di qua e di là dalle Alpi, per permettere loro di muoversi liberamente con documenti e titoli di studio riconosciuti da ambo le parti del confine.
L’appartamento del professor Tolo affaccia su un confine a sua volta. Non servono passaporti per attraversare largo Giachino, ma nel farlo si cammina sul vertice dove si incontrano tre quartieri di Torino: Borgo Vittoria, Madonna di Campagna e la Borgata Tesso.
Trent’anni fa quest’uomo di mezza età, sorridente e posato, ha percorso più di 4000 chilometri per atterrare qui, proprio su largo Giachino, incrocio di semafori in quello che era allora un luogo circondato da fabbriche dentro una città, al tempo, industriale.
Proprio qui, sì:
“Il primo posto in cui sono stato appena arrivato in Italia è stato la Ozanam House, l’ex fonderia su cui ora si affaccia il balcone di casa mia. Sono poi andato altrove, sempre in città, ma da qualche tempo sono tornato. Evidentemente ho un qualche legame con questo quartiere”.

Jean-Baptiste aveva 23 anni quando ha lasciato un Paese che allora aveva persino un altro nome: Dahomey, in seguito ribattezzato Benin nel tentativo di riappropriarsi – usando la denominazione dell’antico regno che si stendeva su quelle terre – delle radici africane, cancellando l’era del colonialismo. “Ma si tratta di scelte politiche, per così dire.” spiega Tolo con il lucido distacco dell’accademico a noi tre lì presenti, che lo ascoltiamo con un occhio a quel che bolle in pentola. “L’antico Benin non è esattamente l’attuale Nazione, pensate che la città di Benin City non si trova nemmeno in Benin, ma in Nigeria!”
Era un ragazzo, Tolo, giovane come tutti quelli che lasciano l’Africa. Pensando di tornarci. Non sapendo, non volendo credere, che non succederà. “Quando uno parte, non lo immagina”, ammette. “Pensa di migliorare la propria vita e poi tornare: più forte, più ricco, migliore. Poi, però…” Poi accade che il traguardo prefissato richieda magari un po’ di tempo in più del previsto per essere raggiunto, solo un altro po’.
Ancora un altro annetto, altri due al massimo. Alla fine, il migrante ci riesce: lavoro, conoscenze, stabilità. Ma a quel punto, dopo aver afferrato l’obiettivo per il quale si è faticato tanto…perché lasciarlo? Nessun uomo rinuncia a ciò che ha conquistato, piccolo o grande che sia il premio. E chi invece non ce la fa, non torna indietro per raccontarlo, subendo l’ingiuria del pubblico fallimento. Salvo eccezioni, c’è una grande verità dietro le migrazioni, che non si dice: chi parte non torna. Sia che si lasci il Sud del proprio paese, sia che si cambi nazione o addirittura continente.
Mentre tre italiani lo osservano incuriositi, Jean-Baptiste si muove con sicurezza in cucina, apre le confezioni dove tiene gli ingredienti per il piatto che preparerà, liberando profumi ignoti: “Adoro gli odori, gli odori sono cultura!”, ride.
“Quando entro in un palazzo, qui a Torino, amo cercare di riconoscere chi ci abita partendo dagli odori.”
“I senegalesi li individuo quasi sempre: c’è un piatto nazionale del Senegal che ha un profumo specifico, mi sembra si chiami thiébou diène, è un piatto a base di riso e pesce… Quando entri in un palazzo dove qualcuno lo sta preparando, beh, te ne accorgi!”.
Anche noi, nella cucina di casa sua, sentiamo degli odori nuovi e misteriosi. Fra tutti, predomina il piment épicé au poisson, contenuto in un barattolino da trattare con il riguardo che si userebbe a una barra di plutonio instabile: è bastato avvicinare il naso al contenitore per non avvertire più l’odore della cipolla, dell’alloro, dell’olio di palma, dello zenzero e delle altre spezie che soffriggevano nella pentola di terracotta.

“È un condimento fatto con peperoncino piccante e pesce essiccato ridotti in polvere”, spiega Jean-Baptiste. “Rispetto a tanti anni fa, ormai anche qui in Italia trovo molti degli ingredienti tipici della cucina beninese, ma questo purtroppo no, questo barattolino l’ho comprato a Porto-Novo l’ultima volta che sono andato, così come il sale iodato che distribuisco fra gli amici quando torno”.
Il nostro anfitrione sta preparando come ricetta l’abobo. “È un bel nome, vero? È bel suono, abobo…” dice, chiedendo conferma. “Si tratta di un piatto semplice a base di fagioli, accompagnati dalla farina di manioca. Si mettono prima i fagioli, poi l’olio di palma e la farina, si mischia tutto e si mangia.
A chi piace il piccante, può aggiungere il preparato di peperoncino”. Ci racconta di aver imparato a farlo da sua mamma, ma di sapere che ne esistono molte varianti possibili: c’è chi mette sopra un po’ di farina di mais, chi lo mischia bene con l’olio rosso, chi aggiunge la manioca a freddo e chi in cottura, ognuno a modo proprio e ognuno rigorosamente convinto, come accade anche in Italia con le ricette locali, che la sua sia la sola versione rispettosa della tradizione.
L’abobo è un piatto comune, che si mangia mediamente un paio di volte a settimana, ma la cui preparazione ha al tempo stesso un che di cerimoniale: lo vedi nell’impiattamento coloratissimo, nei movimenti del cuoco, nel modo in cui spargerà sul piatto finito la farina di manioca, facendola piovere come se stesse rifinendo un’opera d’arte sacra.

L’abobo per i beninesi è casa, è un gesto materno che rassicura, ma è anche quello che oggi qui chiameremmo street food: “Quando ero piccolo e andavo a scuola,” racconta Jean-Baptiste, “durante la ricreazione c’era, lì fuori, una signora che teneva sul fuoco un pentolone enorme, o almeno così lo vedevo con gli occhi di bambino. Si sedeva lì su una riva, come si siedono gli africani, e diceva: “Chiedete pure!”. Preparava un piatto e te lo vendeva per venticinque franchi. Versava un po’ di abobo, aggiungeva dell’olio prendendolo dal fondo, poi la farina di manioca. Questi erano i gesti. Io lo mangiavo, saziandomi fino a sera come si può fare solo con i fagioli”.
Nel frattempo, l’olio frigge. Olio di palma, quello rifuggito come la kryptonite dalle industrie alimentari europee: “Ma l’olio di palma può essere un prodotto di qualità altissima!”, spiega il professore, scuotendo la testa davanti a una moda che ha lambito il confine con l’isteria collettiva. “Questa pubblicità negativa distrugge i paesi africani che hanno basato la loro economia sulla coltivazione di palme e l’estrazione dell’olio. Non si può generalizzare così, scrivendo “senza olio di palma” su tutte le confezioni! Ma restiamo in cucina e cerchiamo di non parlare di politica…”
Il padrone di casa fa arrostire del platano nel forno, i profumi aumentano; i ricordi sono vividi e condivisi: “Ho detto a un amico che avrei preparato l’abobo, e lui subito mi ha risposto: “Che bello! Quello che mangiavamo sempre sulla strada grande!”. C’erano due strade fuori dalla nostra scuola, la signora si piazzava lì all’incrocio, sotto gli alberi, come lei ce n’erano diverse nei vari quartieri della città.”
Prosegue, portandoci in un’Africa simile a quella dell’immaginario comune e romantico sul Continente Nero.
“Al pomeriggio vedevi passare altre donne, con un vaso di terracotta caldo sulla testa, e un cuscino per proteggerle dal calore stesso; dentro il vaso, il latte in cui sciogliere la tapioca. Le signore li portavano camminando, e intanto annunciavano ‘Tapioca, tapioca!’. Ma ne vedi sempre meno, stanno scomparendo. I tempi cambiano, anche in Africa…”.
Quel che non si è perso sotto il giogo della dominazione coloniale francese, inglese e tedesca, rischia di svanire oggi: le tradizioni si spengono con i venti della globalizzazione, che nella sua accezione peggiore passa come una livella sulle differenze culturali, appiattendole anziché dando loro valore. Jean-Baptiste ci parla di come non riesca più a trovare molti piatti tipici, quando fa un viaggio nella sua terra natìa. “Chi mi conosce sa che vivo come un dolore queste perdite e allora mi arrivano le segnalazioni: “Nel tal villaggio fanno ancora il tal piatto in quel modo là”, mi avvisano”. E allora eccolo partire verso l’entroterra, a caccia di memorie.

Memorie personali, familiari, ma anche memorie collettive, di popolo; memorie fatte di foglie, dentro cui vengono avvolti cibi che poi sono cotti al vapore. “Come quei fagottini che mia nonna mi portava dal mercato”, e racconta: “Lo scorso anno ho percorso 80 chilometri per seguirne la segnalazione e alla fine l’ho trovato! Devo dire che quando l’ho addentato, il sapore non era delizioso come quello che la mia memoria aveva conservato e forse migliorato…”.
Anche in Benin stanno nascendo associazioni di agricoltori che, sulla scorta di esempi europei (italiani prima di tutto, si pensi a Slow Food), si battono per il mantenimento di coltivazioni e tradizioni gastronomiche locali. L’occidentalizzazione culturale è forse irreversibile, ma può non essere totalizzante, può non cambiare totalmente le abitudini delle famiglie. Jean-Baptiste se ne rende conto con lo sguardo di chi è profondo conoscitore dei due mondi, e sa attingere indifferentemente dalle due culture. “Al mattino di solito in Benin facciamo colazione mangiando buy. Molti però fanno anche una colazione più tipicamente occidentale, specie in città, dove ormai si consuma più il Nescafé che il buy. Io spesso mangio tradizionale e i miei figli, cresciuti in Italia, si chiedono come io faccia a mangiare certe cose al mattino!”.
La stessa idea che noi abbiamo di colazione è in discussione: “Se dovessi chiedere a mio nonno contadino cosa lui mangi per colazione, non capirebbe. “Colazione” è un concetto che sfugge, lui è un beninese prosaico, si alza, mangia della carne, beve qualcosa e definirebbe il suo pasto mangiare per andare a lavorare.”
Siamo al novantesimo minuto, il tempo di cottura dei fagioli dall’occhio. Questo antico legume si coltiva anche in Italia, ma è originario dell’Africa. Altri ingredienti sono meno reperibili nei nostri negozi, altri ancora, come il pepe, Jean-Baptiste li reputa semplicemente più buoni se acquistati in loco. Per esempio, il pepe, che compra al mercato in Benin, lo sciacqua a lungo, lo setaccia e fa asciugare al sole. E noi tre, ospiti italiani nella sua cucina, possiamo confermare che il profumo ha tutta un’altra forza.

Siamo spesso abituati a pensare che ci si debba aprire alle culture – e quindi alle cucine – del mondo intero, ma è vero che a volte è il migrante a mantenersi gelosamente ancorato alle proprie usanze, senza tastare cosa gli offra il territorio. Non è questo il caso del nostro protagonista, che ci mostra come per il suo prossimo viaggio in Africa abbia già comprato quattro chili di linguine e un barattolone di pesto alla ligure di quello buono, per far apprezzare ai connazionali la cucina italiana.
Triplice fischio, si mangia. Con il pazzesco soffritto del professore, i fagioli e tutto il piatto diventano rosso fuoco; poi, la nevicata di farina di manioca. Come si fa a descrivere un sapore quando non si hanno termini di paragone, quando è semplicemente diverso da ogni pietanza mai provata? Quali parole si possono scegliere, a quali memorie è possibile attingere?
Morbido, pungente e a un tempo quasi dolce: l’abobo non si avvicina a nessuna preparazione europea nota. Potrebbe provenire tranquillamente da un’altra galassia e ci sentiamo molto fortunati a essere invece sullo stesso pianeta. La manioca, i fagioli e l’olio di palma combinati insieme hanno però un riferimento immediato. Richiamano un luogo preciso, che abbiamo conosciuto: Bahia. Ma come può essere, come possono esserci elementi comuni fra due luoghi così distanti fra loro? Non lo sapremmo mai, se non ce lo spiegasse il professore, che sorridendo sussurra: “Eh, c’entra eccome, il Brasile, col Benin…”.
Nel piccolo paese da cui proviene, infatti, molte cose parlano di Brasile: alcuni vocaboli sono prestiti portoghesi (pur essendo i lusitani fra i pochi colonizzatori a non aver messo piede in quello specifico pezzetto d’Africa…), così come nella toponomastica di Salvador ci sono strade che richiamano il Golfo di Guinea. Se antecedentemente a Benin il nome di quella terra era Dahomey, ancor prima si chiamava Costa degli Schiavi. No, non è una citazione del Trono di Spade: quella zona era il principale porto di partenza delle navi negriere, che poi lasciavano il loro triste carico sulle coste di quello che ai nostri tempi chiamiamo Bahia. E oggi, numerosi brasiliani di pelle nera studiano la genealogia cercando di ricostruire le proprie origini, compiendo poi a ritroso il viaggio transoceanico dei propri avi. In molti ogni anno sbarcano in Benin per visitare quei luoghi dove poi versano fiumi di lacrime catartiche.

L’abobo ci delizia, mentre il platano arrosto stempera la fiamma del condimento sui nostri morbidi palati occidentali. Il concetto africano di “piccante” è decisamente su un altro livello rispetto a quello nostrano, e Jean-Baptiste può confermalo in prima persona: “Il piccante che si usa in Italia non è la stessa cosa, credetemi… Io ho sposato una calabrese e un giorno siamo andati nelle sue zone di origine. Ho cucinato io, come cucino di solito. C’era un signore del posto, un amico di famiglia, che voleva a tutti i costi assaggiare il condimento al peperoncino che avevo portato. Io gli dicevo: “Fa’ attenzione, Salvatore, che fa male!”, però lui con sicurezza mi ha risposto: “Ma io sono di Soverato!”.
Ne ha presa una cucchiaiata, la ha mischiata con il riso e ha mandato giù. E da lì, il calvario. Lui nel suo orgoglio non voleva lasciar trasparire che stesse male, io però lo vedevo trattenere spasmi di tosse. Stava male, male davvero! Gli ho chiesto se volesse un po’ d’acqua… L’ha bevuta tutta, ha mangiato un mucchio di pane, ma non smetteva di sudare!”.